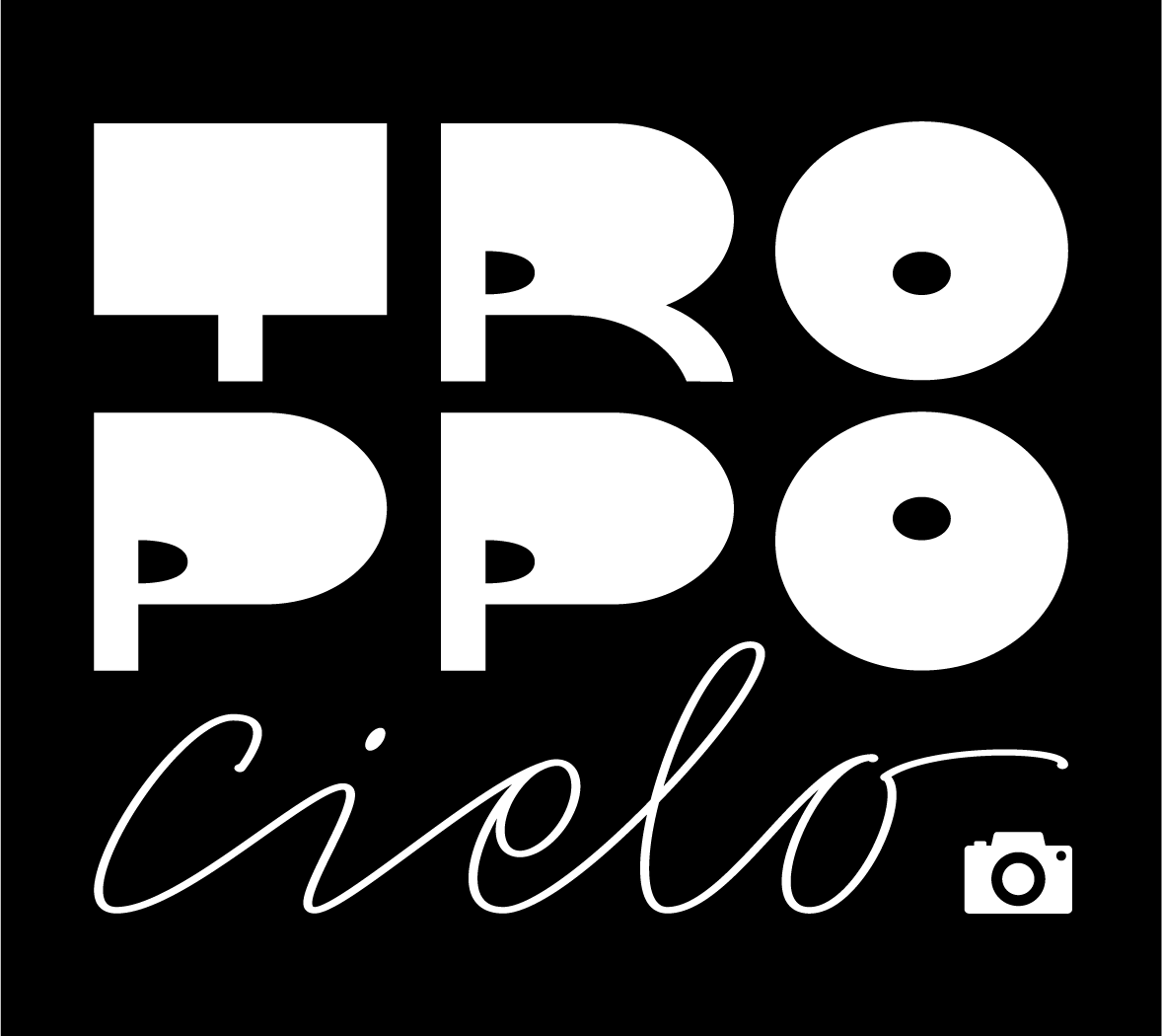Lezione 3
La profondità di campo
Si parla di profondità di campo per indicare l’estensione della zona che risulta nitida (che appare a fuoco).
Per modificare la profondità di campo si varia l’apertura del diaframma. Più aperto è il diaframma, maggiore sarà la sfocatura di ciò che si trova davanti o dietro la linea che è stata messa a fuoco*. Più chiuso è il diaframma, maggiore sarà l’estensione della zona che percepiamo a fuoco osservando la fotografia.
*NB: non si mette a fuoco un singolo oggetto, ma tutti i punti equidistanti dal punto di ripresa... per questo ho parlato di linea messa a fuoco, e non di punto. Per essere precisi, la profondità di campo si estende di circa 1/3 davanti al piano di messa a fuoco e 2/3 dietro.
Altri fattori influenzano la profondità di campo:
La distanza di ripresa.
Più il soggetto è vicino al punto di ripresa, minore sarà la profondità di campo.
La lunghezza focale (cos’è? continua a scorrere in basso)
Maggiore è la lunghezza focale utilizzata e minore sarà la profondità di campo.
La lunghezza focale
La lunghezza focale, espressa in millimetri (mm) determina l’ampiezza dell'angolo di ripresa: un obiettivo che permette di inquadrare un ampio campo visivo viene chiamato “grandangolo” (es. 24mm); uno che cattura una visione simile a quella dell’occhio umano viene chiamato “medio” (35-50mm); uno che ingrandisce molto e riprende cose lontane come fossero vicine si chiama “teleobiettivo” (es. 135mm).*
*NB. I valori numerici espressi negli esempi tra parentesi si riferiscono all’effetto della lunghezza focale su una classica macchina a pellicola (o con un sensore digitale Full-Frame), cioè quando il supporto fotosensibile ha dimensioni 36x24mm. La gran parte dei sensori digitali sono più piccoli della pellicola: mostrano quindi solo un ritaglio di ciò che, a parità di lunghezza focale, si vedrebbe su una pellicola classica. Di fatto, si ottiene così un effetto di zoom (cioè l’effetto di ingrandimento dato da una maggiore lunghezza focale). Il fattore di ingrandimento può variare da una macchina all’altra (di solito è circa 1,5)
Come scegliere la giusta combinazione di tempo e diaframma?
Si deve tenere conto di due fattori: la resa del movimento (del soggetto e della macchina fotografica) e le nostre esigenze di messa a fuoco, ovvero la profondità di campo.
Il movimento della macchina: ‘tempo di sicurezza’
Se il tempo di esposizione è troppo lungo, anche un piccolo movimento del fotografo può rendere una foto mossa. Più lunga è la focale utilizzata (lunghezza focale dell’obiettivo, espressa in mm), più è accentuato il movimento. Perché una foto non risulti mossa a causa del movimento involontario di chi scatta, è consigliabile usare un tempo di esposizione pari a circa 1/ lunghezza focale (ricordate di prendere in considerazione il fattore di ingrandimento del vostro sensore (vedi sopra). Il tempo di sicurezza quindi va calcolato di conseguenza!)
Es. scattando a lunghezza focale: 50mm ⟶tempo di scatto 1/50;
a 28mm ⟶ 1/30;
200mm ⟶ 1/200; ecc.
Il movimento del soggetto
Può succedere di fotografare un soggetto in movimento. Possiamo scegliere di ‘congelare’ il movimento usando un tempo di esposizione sufficientemente breve (movimento del soggetto risulta impercettibile nella durata dello scatto, cioè nel tempo compreso tra l’apertura e la chiusura dell’otturatore). Oppure possiamo scegliere di rendere visibile il movimento (effetto ‘mosso’) anche nella fotografia, con un tempo di esposizione più lungo (il soggetto si muove evidentemente nel tempo dello scatto).
Si può tentare di rendere nitido il soggetto in movimento e mosso tutto il resto con la tecnica del ‘panning’. Si tratta di seguire il movimento del soggetto durante la durata dello scatto. In altre parole, il soggetto dovrebbe occupare sempre la stessa porzione di fotogramma durante lo scatto, mentre la macchina fotografica si muove per seguirne il movimento.
es. panning
Un altro gioco - ‘light painting’ - consiste nel muovere una fonte di luce (es, una torcia) all’interno dell’inquadratura. Per l’effetto cumulativo della luce, si otterrà il disegno del tracciato fatto durante lo scatto (es. in 30 secondi).
es. light painting
La profondità di campo
Se vogliamo sfocare (sfondo o primo piano) dovremo scegliere un diaframma aperto (f/ numero piccolo), se invece lo scopo è mettere a fuoco il più possibile (sia ciò che è vicino che ciò che è lontano), allora dovremo scegliere un diaframma il più possibile chiuso (f/ numero grande)
Vi renderete conto che non sempre è possibile usare la combinazione sperata… sarà molto difficile ‘congelare’ il movimento in situazioni di luce scarsa. Viceversa sarà difficile mostrarlo in condizioni di luce molto forte.
Sfocare lo sfondo mette in risalto il soggetto, ed elimina eventuale disturbo visivo.
Una grande profondità di campo può far sembrare che tutto sia sullo stesso piano, creando effetti particolari e illusioni prospettiche.
Il bilanciamento del bianco
(WB - White Balancing) è l’operazione, automatica o manuale, che permette di interpretare correttamente la luce della scena e restituire colori ‘verosimili’. Questo processo tiene conto del fatto che la luce può essere di diversi colori.
Impostare il corretto bilanciamento del bianco permette di rimuovere colorazioni innaturali e cogliere i “colori reali” degli elementi inclusi della scena. Nell’immagini seguente sono mostrate le più comuni Impostazioni semplificate per correggere il colore delle immagini:
Compiti per casa:
Liberi di provare, sperimentare… potete ripetere gli esercizi dell’altra volta se volete, con un po’ di consapevolezza in più!
Alcuni esempi di esercizi:
Congelare un oggetto in movimento;
Rendere il mosso (eventualmente con effetto panning);
Light painting;
Sfocare lo sfondo e/o il primo piano;
Ottenere molta profondità di campo;
Fare interagire primo piano e sfondo (tipo dita che tengono il sole e cose del genere).
Invia le foto usando il modulo:
https://forms.gle/JMFCtXW3PnZD2weMA
Se il modulo non funziona, faccelo sapere e invia le foto a troppocieloedu@gmail.com.