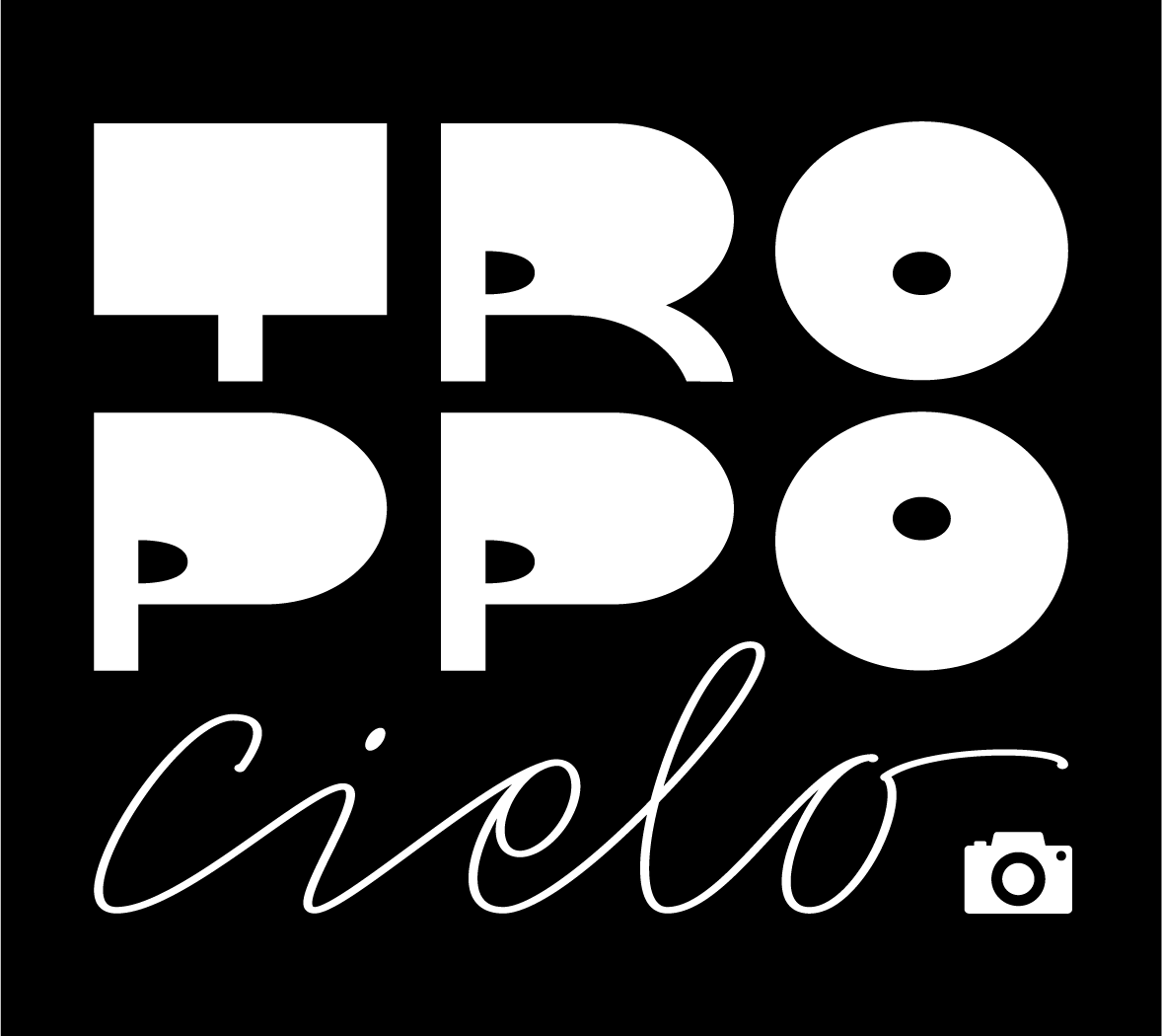Sintesi lezioni + compiti per casa
Corso di Fotografia
Lezione 6
Linguaggio Visivo
Vediamo come siamo. Fotografare e comunicare efficacemente richiede un buon livello di conoscenza del soggetto, ma soprattutto di noi stessi. Ricordate Socrate: “conosci te stesso”.
Una comunicazione visiva potente non si limita a mostrare la realtà, ma rappresenta un punto di vista, un’idea, una riflessione, un’intuizione. Il primo passo è riuscire a rendere un’immagine comprensibile attraverso la composizione, il secondo passo è inserire un messaggio interessante nella foto.
Come? Utilizzando le figure retoriche!
Le figure retoriche in fotografia:
Nella gran parte dei casi si tratta di inserire più di un elemento nell’inquadratura, ma è di fondamentale importanza che i vari elementi inquadrati interagiscano tra di loro (almeno a livello concettuale).
Nella realtà è molto difficile che un elemento sia isolato dal suo contesto. Per questo è necessario osservare bene e notare ogni elemento presente, perché tutto ciò che inquadriamo acquisirà un significato per chi osserva la foto. Quindi…
Attenzione!
La scelta di cosa includere ed escludere deve essere ben ragionata e precisa: deve vedersi chiaramente ciò che deve vedersi, e non si deve vedere ciò che non c’entra nulla con il messaggio che vogliamo trasmettere.
In poche parole, attraverso la composizione, bisogna guidare l’interpretazione del pubblico.
Alcuni sani princìpi da tenere a mente:
1. Ridurre al minimo la confusione visiva (come il ‘rumore’ in una conversazione): evitare sovrapposizione di soggetti, l’accostamento di troppi colori diversi, la presenza di elementi parziali (tagliati o non conclusi), troppi elementi inclusi.
2. Evitare ogni forma di ridondanza: non ripetere elementi già presenti o con significati troppo simili tra loro, usare sempre il numero minimo di elementi strettamente necessari per descrivere la situazione.
3. Ricordare che la narrazione non è svolta nel tempo (come ad esempio nel cinema), ma si sviluppa nello spazio (destra/sinistra, sopra/sotto, davanti/dietro): quindi occhio anche a quello che avviene sullo sfondo o sui bordi della fotografia!
Di seguito alcune figure retoriche di facile applicazione in fotografia:
Accumulazione: serie di termini accostati in modo ordinato e/o caotico come ripetizioni parziali del senso di ognuno.
Allusione: citare un riferimento più o meno noto, trasformandolo a una realtà che lo chiama per alcune caratteristiche.
Analogia: rappresentazione di un’idea attraverso parole con significati diversi collegate tra loro da un concetto astratto.
Anastrofe: inversione dell’ordine abituale di un gruppo di termini successivi.
Antifrasi: consiste nell’usare un’espressione attribuendole un significato opposto a quello a essa proprio, per lo più in senso ironico. Es. dire: ‘che bella giornata’, mentre piove a dirotto.
Antitesi: contrapposizione di idee espressa mettendo in corrispondenza parole di significato opposto o in contrasto.
Cacofonia: accostamento di immagini che produce un effetto esteticamente sgradevole.
Climax: disposizione di termini secondo una gradazione in crescita (climax ascendente). Se la disposizione avviene diminuzione prende il nome di anticlimax.
Ellissi: all’interno di una frase, consiste nell’eliminazione di alcuni elementi al fine di dare al periodo concisione e coesione.
Iperbole: consiste nell’esagerazione nella descrizione della realtà tramite espressioni che l’amplifichino. Es. ‘Ti amo da morire!’
Metafora: è la sostituzione di un termine proprio con uno figurato.
Ossimoro: antitesi di parole differenti fra loro che vengono accostate per dare un senso paradossale.
Reiterazione: consiste nel ripetere lo stesso concetto con altre parole.
Rima: è l’omofonia, ovvero l’identità dei suoni, tra due o più parole (in fotografia si parla di isomorfismo, ovvero di somiglianza tra forme piuttosto che di suoni).
Sineddoche: consiste nell’uso in senso figurato di una parola al posto di un’altra basato su relazioni quantitative (il tutto per la parte; la parte per il tutto).Ricorda che il significato di una fotografia è sempre locale: gli spettatori interpretano la foto basandosi sulla propria comprensione del mondo, e quella dipende da un sacco di cose!
Non importa tanto cosa di fotografa, ma come lo si fotografa e come poi viene mostrato.
Con l’esplorazione profonda di un tema, un fotografo riesce a costruire una sua visione sul soggetto e acquisire la consapevolezza necessarie perché la sua visione (prima) e le sue fotografie (dopo) possano portare un messaggio interessante. Concentrati nel fotografare ciò che ti importa veramente!
Post-Produzione Digitale
La maggior parte dei concorsi fotografici non permette di intervenire sulla foto se non con leggere modifiche:
esposizione
contrasto
bilanciamento del bianco
saturazione e B/N
ritaglio/raddrizzamento
lievi correzioni locali
Finché ci interessa restare all’interno del ‘reame della fotografia’, sarà comunque bene evitare di modificare le foto al punto da alterarne il contenuto (colori alterati, rapporti di luce invertiti, saturazione eccessiva, chiarezza estrema, ecc.).
Compiti per casa:
Esercizio del flaneur: vagabonda e osserva tutto con attenzione. Soffermati su ciò che cattura il tuo sguardo. Scatta foto (sempre esplorando il soggetto, variando il punto di vista, attenzione alla composizione). Scegli 5-6 delle foto che hai scattato, cerca di individuare un filo conduttore, una traccia di chi sei.
Foto con figura retorica, ovvero un’immagine che contenga almeno due elementi che interagiscano tra loro nell’inquadratura.
Invia le foto usando il modulo:
https://forms.gle/JMFCtXW3PnZD2weMA
Se il modulo non funziona, faccelo sapere e invia le foto a troppocieloedu@gmail.com.
Sequenze Fotografiche
Le serie fotografiche offrono la possibilità di parlare di un argomento in maniere più approfondita di quanto si possa fare con una singola foto (per quanto densa possa essere). Inoltre, interagendo tra di loro, più immagini riescono a restringere il campo di interpretazioni e guidano lo spettatore in un discorso ben definito.
Gli elementi tipici di una narrazione sono:
- Alcuni protagonisti
- Un contesto spazio-temporale (storico-geografico)
- Un tema concettuale
Più sono limitati, più il lavoro sarà facile da sviluppare (es. Amore vs. Amore tra teenager in Lapponia)
Tre tipi di sequenza:
Sequenza Tematica: consiste nella ripetizione di un esempio al fine di chiarire e ribadire un concetto ben preciso. Richiede forte coerenza estetica tra le immagini.
Sequenza Cronologica: le foto vengono disposte nell’ordine in cui sono state scattate. Mostrano un evento nella sua normale successione temporale.
Sequenza Logica: è un discorso complesso, in cui grandissimo spazio viene dato alla visione personale di chi compone la narrazione. Importanza particolare hanno la prima e l’ultima foto (apertura e chiusura del discorso).
L’argomento è vasto e richiede un’attenzione dedicata. Se ti interessa approfondire e imparare a creare un racconto con le fotografie, c’è il Corso di Narrazione Visiva di TroppoCielo. Un percorso altamente formativo della durata di tre mesi.
Corso di
Narrazione Visiva
Lezione 5
Ancora sulla composizione:
Attenti ai bordi dell’inquadratura: ciò che sta ai lati ha maggior peso grafico.
Attenti al taglio delle figure. O si taglia bene, o non si taglia.
Di solito, in situazioni di alto contrasto, si espone sulle luci.
Attenti al rapporto tra soggetto e sfondo!
Ritratto
Aspetti esteriori che traducono al meglio i tratti della personalità e la storia del nostro soggetto.
Può essere composto anche da due foto (dittico).
Non tagliare le giunture (polsi, caviglie, collo, ecc.).
Lasciare spazio nella direzione dello sguardo o dell’azione.
Attenzione al punto di ripresa (dal basso, dall’alto…)
Paesaggio
Soggetto: terra o cielo?
Suggerire la profondità. Alcuni esempi:
sole basso nel cielo, ombre lunghe e morbide (mattina e sera)
prospettiva aerea (diminuzione di nitidezza all’aumentare della distanza)
inclusione di elementi riconoscibili (di forma e dimensioni note)
riempire il primo piano (includere qualcosa nella parte bassa dell’inquadratura)
cercare di coprire (o non inquadrare) le fonti di luce (sole, lampioni, ecc.)
Compiti per casa:
1 foto di Ritratto (foto singola o dittico).
Deve dire qualcosa sulla persona ritratta. Come? Attraverso un particolare, un dettaglio, un tratto, un’azione, una postura, uno sguardo, un oggetto o quello che vi potete inventare.1 foto di Paesaggio diurno (dall’alba al tramonto)
1 foto di Paesaggio notturno (dal crepuscolo all’oscurità)
In tutto 3 o 4 foto.
NB. Attenzione sempre a luce e composizione.
Invia le foto usando il modulo:
https://forms.gle/JMFCtXW3PnZD2weMA
Se il modulo non funziona, faccelo sapere e invia le foto a troppocieloedu@gmail.com.
Lezione 4
Visione umana e visione della macchina
La visione umana è selettiva: notiamo ciò che il cervello di dice di notare. La macchina riprende tutto in maniera indiscriminata. Chi osserverà la foto non sarà collegato al nostro cervello per capire cosa deve notare… bisogna rendere l’immagine ‘comprensibile’, attraverso la scelta sapiente dell’inquadratura.
La composizione
Comporre significa ‘mettere insieme’ elementi (reali e grafici). Per farlo, occorre cercare il punto di vista ottimale, stando attenti ad includere ciò che serve ed escludere ciò che non serve.
Prima di scattare farsi le domande:
qual’è il soggetto?
che rapporto ha col contesto?
quanto spazio deve occupare nell’inquadratura?
Esistono dei principi generali che è bene seguire (nella gran parte dei casi) per aiutare lo spettatore nella comprensione chiara ed immediata del contenuto della foto. Non si tratta di ‘regole’, ma di ‘strategie’:
equilibrio grafico (disporre elementi in modo bilanciata)
rapporto soggetto/sfondo (ricercare contrasto)
rapporto primo piano/soggetto (cornici)
evitare le sovrapposizioni
individuare pattern/ripetizioni
notare presenza di linee guida
cercare punti di vista originali (inusuali)
riflessi e trasparenze (specchi, vetri, pozzanghere, ecc.)
occhio elementi grafici non materiali (ombre, riflessi)
attenzione al colore (pochi colori, colori complementari)
attenzione alla luce! (qualità e direzione)
Compiti per casa:
3-4 foto dello stesso soggetto da punti di vista molto diversi tra loro.
Facoltativo (ma consigliato):
3-4 foto scattate nell’arco di una mezz’oretta, passeggiando, con attenzione ad uno o più principi della composizione.
1 foto in cui sia evidente un colore.
Invia le foto usando il modulo:
https://forms.gle/JMFCtXW3PnZD2weMA
Se il modulo non funziona, faccelo sapere e invia le foto a troppocieloedu@gmail.com.
Lezione 3
La profondità di campo
Si parla di profondità di campo per indicare l’estensione della zona che risulta nitida (che appare a fuoco).
Per modificare la profondità di campo si varia l’apertura del diaframma. Più aperto è il diaframma, maggiore sarà la sfocatura di ciò che si trova davanti o dietro la linea che è stata messa a fuoco*. Più chiuso è il diaframma, maggiore sarà l’estensione della zona che percepiamo a fuoco osservando la fotografia.
*NB: non si mette a fuoco un singolo oggetto, ma tutti i punti equidistanti dal punto di ripresa... per questo ho parlato di linea messa a fuoco, e non di punto. Per essere precisi, la profondità di campo si estende di circa 1/3 davanti al piano di messa a fuoco e 2/3 dietro.
Altri fattori influenzano la profondità di campo:
La distanza di ripresa.
Più il soggetto è vicino al punto di ripresa, minore sarà la profondità di campo.
La lunghezza focale (cos’è? continua a scorrere in basso)
Maggiore è la lunghezza focale utilizzata e minore sarà la profondità di campo.
La lunghezza focale
La lunghezza focale, espressa in millimetri (mm) determina l’ampiezza dell'angolo di ripresa: un obiettivo che permette di inquadrare un ampio campo visivo viene chiamato “grandangolo” (es. 24mm); uno che cattura una visione simile a quella dell’occhio umano viene chiamato “medio” (35-50mm); uno che ingrandisce molto e riprende cose lontane come fossero vicine si chiama “teleobiettivo” (es. 135mm).*
*NB. I valori numerici espressi negli esempi tra parentesi si riferiscono all’effetto della lunghezza focale su una classica macchina a pellicola (o con un sensore digitale Full-Frame), cioè quando il supporto fotosensibile ha dimensioni 36x24mm. La gran parte dei sensori digitali sono più piccoli della pellicola: mostrano quindi solo un ritaglio di ciò che, a parità di lunghezza focale, si vedrebbe su una pellicola classica. Di fatto, si ottiene così un effetto di zoom (cioè l’effetto di ingrandimento dato da una maggiore lunghezza focale). Il fattore di ingrandimento può variare da una macchina all’altra (di solito è circa 1,5)
Come scegliere la giusta combinazione di tempo e diaframma?
Si deve tenere conto di due fattori: la resa del movimento (del soggetto e della macchina fotografica) e le nostre esigenze di messa a fuoco, ovvero la profondità di campo.
Il movimento della macchina: ‘tempo di sicurezza’
Se il tempo di esposizione è troppo lungo, anche un piccolo movimento del fotografo può rendere una foto mossa. Più lunga è la focale utilizzata (lunghezza focale dell’obiettivo, espressa in mm), più è accentuato il movimento. Perché una foto non risulti mossa a causa del movimento involontario di chi scatta, è consigliabile usare un tempo di esposizione pari a circa 1/ lunghezza focale (ricordate di prendere in considerazione il fattore di ingrandimento del vostro sensore (vedi sopra). Il tempo di sicurezza quindi va calcolato di conseguenza!)
Es. scattando a lunghezza focale: 50mm ⟶tempo di scatto 1/50;
a 28mm ⟶ 1/30;
200mm ⟶ 1/200; ecc.
Il movimento del soggetto
Può succedere di fotografare un soggetto in movimento. Possiamo scegliere di ‘congelare’ il movimento usando un tempo di esposizione sufficientemente breve (movimento del soggetto risulta impercettibile nella durata dello scatto, cioè nel tempo compreso tra l’apertura e la chiusura dell’otturatore). Oppure possiamo scegliere di rendere visibile il movimento (effetto ‘mosso’) anche nella fotografia, con un tempo di esposizione più lungo (il soggetto si muove evidentemente nel tempo dello scatto).
Si può tentare di rendere nitido il soggetto in movimento e mosso tutto il resto con la tecnica del ‘panning’. Si tratta di seguire il movimento del soggetto durante la durata dello scatto. In altre parole, il soggetto dovrebbe occupare sempre la stessa porzione di fotogramma durante lo scatto, mentre la macchina fotografica si muove per seguirne il movimento.
es. panning
Un altro gioco - ‘light painting’ - consiste nel muovere una fonte di luce (es, una torcia) all’interno dell’inquadratura. Per l’effetto cumulativo della luce, si otterrà il disegno del tracciato fatto durante lo scatto (es. in 30 secondi).
es. light painting
La profondità di campo
Se vogliamo sfocare (sfondo o primo piano) dovremo scegliere un diaframma aperto (f/ numero piccolo), se invece lo scopo è mettere a fuoco il più possibile (sia ciò che è vicino che ciò che è lontano), allora dovremo scegliere un diaframma il più possibile chiuso (f/ numero grande)
Vi renderete conto che non sempre è possibile usare la combinazione sperata… sarà molto difficile ‘congelare’ il movimento in situazioni di luce scarsa. Viceversa sarà difficile mostrarlo in condizioni di luce molto forte.
Sfocare lo sfondo mette in risalto il soggetto, ed elimina eventuale disturbo visivo.
Una grande profondità di campo può far sembrare che tutto sia sullo stesso piano, creando effetti particolari e illusioni prospettiche.
Il bilanciamento del bianco
(WB - White Balancing) è l’operazione, automatica o manuale, che permette di interpretare correttamente la luce della scena e restituire colori ‘verosimili’. Questo processo tiene conto del fatto che la luce può essere di diversi colori.
Impostare il corretto bilanciamento del bianco permette di rimuovere colorazioni innaturali e cogliere i “colori reali” degli elementi inclusi della scena. Nell’immagini seguente sono mostrate le più comuni Impostazioni semplificate per correggere il colore delle immagini:
Compiti per casa:
Liberi di provare, sperimentare… potete ripetere gli esercizi dell’altra volta se volete, con un po’ di consapevolezza in più!
Alcuni esempi di esercizi:
Congelare un oggetto in movimento;
Rendere il mosso (eventualmente con effetto panning);
Light painting;
Sfocare lo sfondo e/o il primo piano;
Ottenere molta profondità di campo;
Fare interagire primo piano e sfondo (tipo dita che tengono il sole e cose del genere).
Invia le foto usando il modulo:
https://forms.gle/JMFCtXW3PnZD2weMA
Se il modulo non funziona, faccelo sapere e invia le foto a troppocieloedu@gmail.com.
Lezione 2
Quantità di luce: la corretta esposizione
L’esposizione è determinata dalla quantità di luce che colpisce il supporto fotosensibile.
Viene chiamata ‘corretta esposizione’ quella che rende il soggetto ben visibile: una fotografia quindi né troppo chiara (sovraesposta), né troppo scura (sottoesposta).
L’Esposimetro
Per aiutarci a stabilire quale quantità di luce sia necessaria perché l’immagine sia ben visibile, la macchina fotografica ci aiuta con uno strumento chiamato ‘esposimetro’ (misura la luce riflessa dall’area inquadrata).
Il grafico dell’esposimetro si esprime (circa) così:
Quando indica lo 0 (‘zero’, la tacca centrale) significa che scattando con quelle determinate impostazioni (tempi, diaframmi, ISO) la zona che siamo puntando risulterà esposta correttamente e diventerà di una tonalità di ‘grigio neutro’ (cioè a metà strada tra il bianco e il nero). La macchina non sa cosa è bianco e cosa è nero! Si limita ad indicarci cosa fare per ottenere una foto né troppo chiara, né troppo scura (v. bicchiere riempito a metà).
Se indica - o +, probabilmente dobbiamo correggere le impostazioni per fare entrare più o meno luce.
Come? Cambiando il tempo di esposizione, l’apertura del diaframma, e al limite gli ISO.
NB: le macchine posso usare diverse modalità di misurazione dell’esposizione (es. spot centrale, matrix, ecc.). Decidete quale fa più al caso vostro, fate delle prove, e ricordatevi quale avete scelto!
Nelle macchine fotografiche moderne sono principalmente due i meccanismi che ci permettono di controllare la quantità di luce che passerà attraverso il foro, determinando l’esposizione finale.
Il tempo di esposizione
Disponibile in varie forme (a seconda del modello della macchina), l’otturatore svolge sempre la stessa funzione: si apre e si chiude, permettendo alla luce di attraversarlo solo per un lasso di tempo determinato, comunemente chiamato ‘tempo di esposizione’. Questo lasso di tempo viene misurato in secondi e frazioni di secondo. Alcuni esempi di tempi sono i seguenti (dal più breve al più lungo):
... 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1” 2” ecc. *
* Alcune macchine fotografiche consentono di utilizzare anche tempi intermedi tra quelli elencati.
Più lungo è il tempo di esposizione, più chiara sarà la foto. E viceversa.
Al raddoppiare del tempo raddoppia l’esposizione.
La differenza d’esposizione viene misurata, nel gergo fotografico, in ‘stop’.
La differenza tra un tempo e il suo doppio – o la sua metà – è di ‘uno stop’.
Le aperture del diaframma
Il diaframma è un’apertura regolabile che determina la quantità di luce che passa e colpisce il sensore. Chiaramente, a parità di tempo, un’apertura maggiore lascia passare più luce rispetto ad una minore. Più aperto è il diaframma, più chiara sarà la foto. E viceversa.
L’apertura del diaframma è indicata da un numero preceduto ‘f/’.
Più piccolo è il numero, maggiore è l’apertura.
La scala standard dei diaframmi (dal più aperto al più chiuso) è la seguente:
f/1 f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32 ecc.*
* Alcune macchine fotografiche consentono di utilizzare anche aperture intermedie tra quelle elencate.
Ad ogni intervallo l’esposizione raddoppia – o si dimezza. Cambia quindi di ‘uno stop’.
Non preoccupatevi di memorizzare intervalli e numeri del diaframma…
L’importante è ricordare che più piccolo è il numero, più è aperto il diaframma (passa quindi più luce)!
NB: si può ottenere la stessa esposizione con varie combinazioni di tempi e diaframmi.
Gamma Dinamica (detta anche Latitudine di Posa)
Non dimenticatevi questo concetto importante!!
Pellicole e sensori hanno un limite: non riescono a registrare la gamma di luci che riusciamo a vedere ad occhio nudo. Cosa vuol dire? Che in situazioni di alto contrasto non è sempre possibile esporre in modo ottimale sia le luci che le ombre (le zone molto chiare e e le zone scure tenderanno a perdere dettaglio, fino a diventare illeggibili, diventando sempre più bianche o nere).
In molti casi sarà quindi necessario esporre correttamente solo una porzione dell’inquadratura, sovraesponendo o sottoesponendo la parte che non interessa (che tenderà quindi a diventare bianca o nera).
Oppure, una volta riconosciuta la differenza di intensità dell’illuminazione nella scena, si può decidere di escluderne dall’inquadratura una parte (quella troppo chiara o troppo scura) e risolvere il problema alla radice!
In molti casi pratici la cosa si traduce nell’evitare di includere nella stessa inquadratura la fonte di luce e il soggetto illuminato (es. lampada e oggetto, cielo e terra, ecc.).
Compiti per casa:
1 foto: soggetto fermo con illuminazione debole (es. al chiuso, luce artificiale, penombra);
1 foto: soggetto fermo con illuminazione forte (es. all’aperto, in pieno giorno, luce solare);
1 foto: soggetto in movimento con illuminazione debole;
1 foto: soggetto in movimento con illuminazione forte.
Foto facoltative:
1 foto con effetto panning.
Scattare con un tempo relativamente lungo (es. 1/15 di secondo) una foto di un soggetto in movimento (es. persona che cammina). Il movimento del soggetto dovrebbe essere perpendicolare rispetto al punto di ripresa. La macchina fotografica inizia a muoversi alla velocità del soggetto prima dello scatto, per continuare il movimento alla stessa andatura durante lo scatto.
(Meglio se lo sfondo presenta irregolarità e dettagli, così si avrà la percezione di movimento in foto.)
Il punto è mantenere il soggetto sempre nella stessa porzione dell’inquadratura, così sembrerà che il soggetto sia fermo mentre lo sfondo si muove.1 foto con light painting.
Serve un ambiente di totale oscurità. Posizionare la macchina immobile da qualche parte. Impostare un tempo di scatto di 30 secondi (appare scritto 30’’). Quando si apre l’otturatore posizionarsi di fronte alla macchina e scrivere/disegnare puntando la torcia contro la macchina fotografica. Attenzione: tutto ciò che viene illuminato durante lo scatto apparirà in foto, mentre ciò che rimane in ombra sarà nero. La luce diretta verso la macchina fotografica creerà dei disegni luminosi.Totale: 4 foto (max 6) da inviare.
PS. Provate anche ad ottenere la stessa esposizione usando diversi rapporti tempo/diaframma (inclusa massima e minima apertura del diaframma… il numero con la ‘f/’ davanti). Può essere necessario appoggiare la macchina, affinché stia immobile durante lo scatto.
Non serve inviare queste foto.
Invia le foto usando il modulo:
Lezione 1
“Non colui che ignora l’alfabeto, bensì colui che ignora la fotografia sarà l’analfabeta del futuro.”
Walter Benjamin
Quanti sono gli scopi della fotografia?
Fotografia non è una disciplina monolitica. Esistono infiniti scopi per fotografare, ed è bene cominciare a capire le proprie intenzioni prima di iniziare ad avventurarsi in questo percorso.
Ricordiamoci anche che il senso (o valore, o efficacia) di un’immagine cambia al variare del contesto e del pubblico a cui l’immagine viene mostrata. Si parla di polivalenza semantica.
(Es. La stessa foto viene interpretata diversamente se viene stampata ed esposta in un museo o caricata in formato digitale su un social network).
Quindi chiediti:
perché scatti delle foto (e a chi le vuoi mostrare)?
da cosa dipendono i tuoi gusti?
Benefici: la fotografia è uno strumento molto valido per cercare di conoscere noi stessi.
La macchina fotografica
Una scatola buia con un piccolo foro.
La scoperta della fotografia risale addirittura a millenni fa (fin da Aristotele). Aveva notato che che la luce, passando attraverso un foro, disegna un’immagine sulla superficie opposta al foro. Ma solo più di recente, nel XIX secolo, si è riusciti a fissare l’immagine in maniera indelebile su una superficie fotosensibile (v. Niépce 1926 e Daguerre 1839).
Un momento decisivo nella storia della fotografia è stata la diffusione del piccolo formato (chiamato “35mm”: le classiche pellicole) che ha permesso di ridurre le dimensioni delle macchine fotografiche e ha fortemente contribuito al processo di massificazione della fotografia a livello globale ( dalla seconda metà ‘900).
Oggi esistono tantissimi modelli di macchine fotografiche, ma non ce n’è uno adatto a tutti gli scopi.
Le macchine fotografiche moderne più comuni sono compatte, bridge, reflex e mirrorless. Ciascuna presenta vantaggi e svantaggi (relativi a dimensioni e peso, qualità dell’immagine, versatilità, intercambiabilità delle lenti, prezzo, ecc.).
Non dimentichiamoci degli smartphone, probabilmente le fotocamere più diffuse al giorno d’oggi.
File digitali: Raw e JPG
JPG: È un formato compresso, quindi relativamente leggero. Il JPG è un’immagine finita, elaborata dal software della macchina. Può essere modificato successivamente al computer, ma con perdita di dati, quindi di qualità.
RAW: È un formato pesante. È un insieme di informazioni e non può essere usato come immagine senza post-produzione digitale. Potremmo essere paragonato al vecchio negativo (infatti viene anche chiamato ‘negativo ‘digitale’).
Qualità e direzione della luce
La qualità della luce può essere definita tra i due estremi di luce dura e luce morbida. La qualità della luce dipende principalmente dalla dimensione della fonte di luce. Cosa cambia?
Dura (diretta) – fonte di luce piccola: ombre nette, alto contrasto tra zone di massimo e minima luminosità. (Es. luce in una giornata limpida di sole nel pieno pomeriggio.)
Morbida (diffusa) – fonte di luce grande: ombre sfumate, basso contrasto tra zone di massima e di minima luminosità. (Es. luce in una giornata nuvolosa, o di nebbia.)
La direzione della luce, nel caso di illuminazione naturale (il sole), dipende soprattutto dal posizionamento del fotografo rispetto al soggetto.
Messa a fuoco automatica (AF-S con punto centrale)
Puntare la macchina mettendo al centro del mirino l’elemento da mettere a fuoco. Premere a metà il pulsante di scatto: la macchina cerca di mettere a fuoco alla distanza desiderata. Finché il pulsante di scatto viene tenuto premuto a metà il fuoco rimane fisso alla stessa distanza. Cambiare l’inquadratura e comporre come meglio si crede. Premere fino in fondo il pulsante di scatto.
Compiti per casa:
Scegli 3 immagini che ti colpiscono, di cui vorresti essere l’autore. Invia le foto il modulo:
Esercizio quotidiano: cerca di riconoscere la qualità della luce nelle fotografie che ti piacciono. Noti delle ricorrenze? La luce modifica il modo in cui vedi le cose? Certo che si! Come?